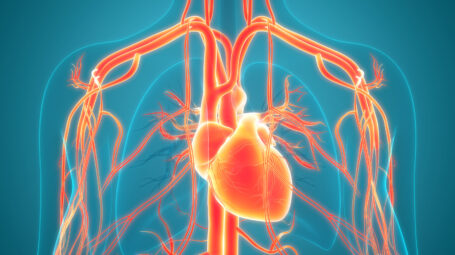“Ringrazio per la vicinanza. Continuate a pregare per me”. Sono queste le parole che Papa Francesco ha condiviso sui social tramite Vatican News, il servizio informativo ufficiale della Santa Sede.
La richiesta di preghiera ai fedeli è arrivata dopo la notizia di un aggravamento delle sue condizioni di salute: gli ultimi bollettini del Policlinico Gemelli parlano di “una polmonite bilaterale che ha richiesto un’ulteriore terapia farmacologica”.
Bergoglio era stato ricoverato lo scorso 14 febbraio per una “bronchite su base infettiva” e gli esami condotti fino a lunedì avevano mostrato una “infezione polimicrobica”, ovvero la presenza nelle vie respiratorie di microrganismi di specie differenti. Adesso si aggiunge un ulteriore tassello.
Ma cos’è la polmonite bilaterale? Quali rischi comporta?
Che cos’è la polmonite bilaterale
La polmonite è una patologia respiratoria acuta, che nella maggior parte dei casi è causata da un’infezione batterica, virale o, più raramente, micotica (funghi).
Nel primo caso, i batteri responsabili possono essere ad esempio il Mycoplasma pneumoniae, l’Haemophilus influentiae e talvolta la Legionella pneumophila, ma la forma più nota e frequente è quella che deriva dallo Streptococcus pneumoniae, più famoso come Pneumococco, da cui dipende circa il 30-50% delle polmoniti acquisite in comunità, cioè contratte a casa propria o in luoghi affollati, all’esterno comunque di ospedali e strutture di lunga degenza.
«Nella maggior parte dei casi l’infezione coinvolge un solo polmone, ma esistono forme bilaterali dove sono interessati entrambi», spiega il dottor Alberto Perboni, direttore della Struttura Complessa di Pneumologia presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, Torino.
«Spesso, ma non necessariamente, la polmonite bilaterale è più severa rispetto a quella monolaterale: molto dipende dalle condizioni generali del paziente, dall’estensione dei focolai infettivi e dall’agente patogeno che ha scatenato il problema».
A confronto con le polmoniti causate da un unico patogeno, quelle polimicrobiche dove i polmoni sono colpiti da più agenti contemporaneamente (come nel caso di Papa Francesco) possono essere di più complessa gestione.
La “complicanza” del Papa
Se li osserviamo, i polmoni somigliano a due alberi visti al rovescio, il cui tronco si dirama verso il basso. Collegati tra loro dalla trachea, che si divide nei due bronchi principali, destro e sinistro, ogni polmone è composto poi da unità più piccole, i lobi, vere e proprie strutture indipendenti sia dal punto di vista anatomico che funzionale.
Il polmone destro è formato da tre lobi: superiore, medio e inferiore. Il polmone sinistro solo da due, superiore e inferiore, a causa della presenza del cuore che come sappiamo è localizzato prevalentemente a sinistra. A sua volta, ogni lobo è diviso in più parti, i segmenti, che ricevono aria e sangue da bronchi e vasi sanguigni dedicati.
Ci sono polmoniti che colpiscono uno o più segmenti broncopolmonari, con poco danno ai segmenti adiacenti, che in condizioni normali sono in grado di garantire la funzione respiratoria.
«Papa Francesco parte da una condizione di svantaggio, perché a 21 anni gli era stato asportato il lobo superiore del polmone destro, sempre a causa di una grave forma di infezione del polmone», ricorda l’esperto. «Questo significa che il Pontefice presenta una minore capacità respiratoria, che potrebbe metterlo in difficoltà e determinare sintomi più severi».
Quali sono i sintomi della polmonite bilaterale
Come in tutte le infezioni respiratorie, nella polmonite è presente la tosse, accompagnata da fiato corto, brividi, debolezza, battito cardiaco accelerato, malessere generale, perdita di appetito, dolore al petto e talvolta febbre.
«Alcuni sintomi possono renderla simile all’influenza, con cui però non condivide la stagionalità: nonostante sia più frequente nei mesi invernali, di polmonite ci si può ammalare tutto l’anno, anche d’estate», evidenzia il dottor Perboni. «Il rialzo della temperatura è più tipico dei soggetti giovani, perché negli anziani la risposta immunitaria è meno vivace e può non attivare la febbre, rendendo più difficoltosa la diagnosi».
In questo caso, gli specialisti prendono in considerazione anche elementi come il calo di attenzione e la sensazione di confusione e disorientamento, perché la polmonite determina uno stato infiammatorio generale che può causare sintomi non specifici del polmone, ma anche alterazioni dello stato di vigilanza e attenzione.
Polmonite bilaterale, quali sono i fattori di rischio
L’anzianità rappresenta un fattore di rischio per la polmonite, perché l’avanzare degli anni è associato a una minore funzionalità delle difese immunitarie, ma a compromettere i meccanismi di difesa possono essere anche patologie polmonari croniche (come BPCO e asma), fumo di sigaretta, diabete, cardiopatie, insufficienza renale, cirrosi epatica, tumori o trapianti d’organo.
«Tutto ciò che può “deteriorare” il sistema immunitario lascia l’organismo più vulnerabile alle infezioni, anche quelle meno comuni», precisa il dottor Perboni.
Come si diagnostica la polmonite bilaterale
Per diagnosticare con certezza la polmonite – mono o bilaterale – è indispensabile una visita accurata del medico, che potrà raccogliere la sintomatologia del paziente e rilevare alcuni rumori tipici (crepitii) auscultando petto e schiena con un fonendoscopio.
Oltre a questi dati clinici, sono importanti quelli bioumorali ottenuti tramite specifici esami del sangue che mostrano, per esempio, un rialzo dei globuli bianchi (soprattutto dei neutrofili in caso di infezione batterica) e dei principali indici di infiammazione (VES, PCR).
A ulteriore conferma si può ricorrere a esami di imaging, come radiografia del torace, ecografia toracica o TC del torace, per evidenziare eventuali addensamenti, cioè la presenza di aree non “arieggiate” dei polmoni che risultano più compatte, perché piene di catarro, globuli bianchi, cellule del sangue e altro materiale.
Come si cura la polmonite bilaterale
Una volta accertata, la polmonite deve essere trattata con il riposo, l’assunzione di molti liquidi e la somministrazione di uno o più antibiotici, se l’origine è batterica, o eventualmente di antivirali o antimicotici, efficaci su alcuni virus e funghi.
«In generale, la terapia antibiotica può essere mirata oppure empirica», spiega il dottor Perboni. «Nel primo caso, si utilizza un farmaco specifico per quel particolare microrganismo, individuato esaminando l’espettorato del paziente oppure un campione proveniente da bronchi e polmoni del paziente, ottenuto attraverso una broncoscopia».
È un po’ come accade nella cistite quando ci si sottopone all’urinocoltura con antibiogramma, un test di laboratorio che valuta gli antibiotici più efficaci sul ceppo batterico individuato.
«Qualora non sia possibile attendere i risultati dei test microbiologici, per cui occorre qualche giorno, si utilizza la cosiddetta terapia empirica, basata sull’esperienza: in sostanza, si ricorre ai trattamenti suggeriti dalle linee guida internazionali che tengono conto dell’età del paziente, delle sue condizioni generali, della storia clinica passata e recente, dell’eventuale esposizione a fattori di rischio, come un ricovero ospedaliero», chiarisce l’esperto.
In quanto tempo si guarisce
Nei soggetti in buona salute, grazie agli opportuni trattamenti, la sintomatologia è il primo aspetto a trarre giovamento: nell’arco di 2-3 giorni, diminuiscono la febbre, la tosse, lo stato di malessere generale.
Entro 5-6 giorni migliorano anche i valori nel sangue, mentre spesso occorre oltre un mese per avere esami di imaging “normali”.
Polmonite bilaterale, ci sono anche i vaccini
Per ridurre la possibilità di contrarre la polmonite o diminuirne l’impatto sull’organismo, esistono diversi vaccini. Tra questi, quello contro l’infezione da Pneumococco viene consigliato soprattutto alle persone a rischio, anziani, portatori di patologie croniche, immunodepressi e diabetici. Non va ripetuto ogni anno come quello influenzale, ma il ciclo vaccinale prevede solo una somministrazione, seguita da un’altra che permette di ottenere una copertura più completa possibile contro ceppi diversi di Pneumococco.
«In questo modo possiamo proteggerci non solo dalla polmonite più comune, ma anche dalle sue possibili complicanze. Tra queste, molto temibile è la sepsi, caratterizzata dal fatto che l’infezione non resta più localizzata solamente nei polmoni, ma entra in circolo nel sangue e diventa più difficile da controllare, anche perché scatena una risposta infiammatoria in tutto l’organismo», conclude il dottor Perboni.
Fai la tua domanda ai nostri esperti