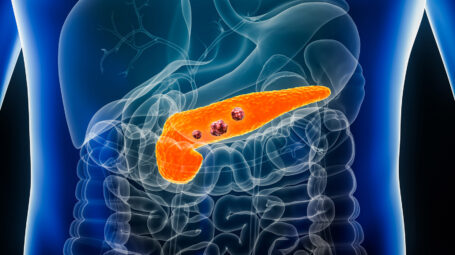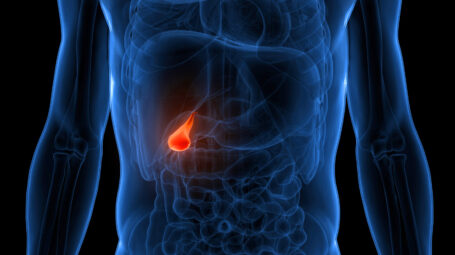Pancreatite: cos’è, sintomi, cause, trattamenti
La pancreatite è un’infiammazione del pancreas, che può essere acuta o cronica. Richiede un approccio multidisciplinare per evitare che evolva verso una forma severa, pericolosa per la vita

“Martedì mi sono sentita male, pensavo di avere l’influenza, sono corsa al pronto soccorso e invece ho la pancreatite acuta”.
Luciana Littizzetto ha spiegato così la sua assenza all’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, il programma televisivo di Fabio Fazio. “Ho aspettato un po’ a farmi vedere, aspettando che passasse. Ho imparato che quando hai sintomi molto forti, che non hai mai avuto prima, è meglio farsi controllare”.
La pancreatite acuta è una problematica piuttosto comune in gastroenterologia: secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità, ogni anno colpisce 5-6 italiani ogni 100 mila abitanti, soprattutto nella fascia di età tra 40 e 80 anni.
Che cos’è la pancreatite
«La pancreatite è un’infiammazione del pancreas, che può presentarsi in forma acuta o cronica», spiega il dottor Matteo Goss, gastroenterologo di Clinica Sedes Sapientiae e Humanitas Cellini a Torino.
La forma acuta esordisce in maniera improvvisa e violenta, solitamente è di breve durata e può essere classificata come lieve, moderata o grave; la forma cronica, invece, si instaura lentamente, fino a causare danni permanenti al pancreas.
«La forma acuta richiede un’ospedalizzazione, non si può curare a casa, e lo stesso vale per la pancreatite cronica al momento della scoperta», tiene a sottolineare l’esperto. «Tra l’altro, mentre la prima è reversibile se trattata con tempestività, l’infiammazione cronica danneggia il pancreas in modo permanente e può aprire la strada a un tumore nel corso del tempo».
Quali sono i sintomi della pancreatite
La pancreatite acuta provoca un forte dolore nella parte alta dell’addome, simile a una pugnalata, che si irradia alla schiena come una barra che trafigge. Possono comparire anche nausea, vomito, distensione addominale (aumento del volume dell’addome) e alvo chiuso sia alle feci che ai gas.
«Qualora evolva verso lo stadio più severo, compaiono anche febbre, tachicardia, ipotensione e compromissione respiratoria, perché la pancreatite diventa una malattia multiorgano e complessa da far rientrare», ammette il dottor Goss.
Nel caso della forma cronica, invece, è tipico un dolore sordo e continuo sempre nella parte alta dell’addome, ma compare anche diabete e si sviluppa malassorbimento, per cui il paziente non riesce più ad assorbire molti micro e macronutrienti (come le vitamine liposolubili A, E, D e K) e può manifestare steatorrea, cioè feci grasse, chiare e che tendono a galleggiare nell’acqua.
Quali sono le cause della pancreatite
Nell maggior parte dei casi, la pancreatite acuta è causata da calcoli biliari che, migrando all’esterno della cistifellea, possono determinare un’ostruzione del dotto pancreatico e impedire il normale deflusso degli enzimi pancreatici verso l’intestino.
«La conseguenza è che il pancreas si infiamma e la sua funzionalità viene ridotta o compromessa», evidenzia il dottor Goss. «Un’altra causa piuttosto comune di pancreatite è l’abuso di alcol, ma alla base può esserci anche l’utilizzo di alcuni farmaci, come certi antipertensivi, antinfiammatori e antipiretici. Qualora si assumano dei medicinali, soprattutto in forma cronica, è sempre bene leggere attentamente il foglietto illustrativo per capire se esiste questa eventualità e controllare periodicamente i valori degli enzimi pancreatici nel sangue, sempre su consiglio medico».
Altre possibili cause di infiammazione del pancreas sono i livelli molto elevati di trigliceridi (superiori a 1000 mg/dl) o un processo infiammatorio sistemico autoimmune, seppure più raro. «Nel caso della pancreatite cronica, invece, i principali fattori di rischio sono l’abuso di alcol, il fumo di sigaretta, una reazione autoimmunitaria a carico del pancreas, una predisposizione genetica o un’ostruzione cronica del dotto pancreatico a causa di calcoli, cisti o un tumore», descrive l’esperto.
Come si diagnostica la pancreatite
Oltre all’anamnesi approfondita, occorre determinare nel sangue gli enzimi pancreatici (amilasi, lipasi) e gli indici di flogosi (come PCR e VES).
Lo specialista può ricorrere poi a tomografia computerizzata (TAC), risonanza magnetica, colangio-pancreatografia retrograda endoscopica (ERCP) o ecoendoscopia, a seconda della causa ricercata.
Come si cura la pancreatite
Il trattamento della pancreatite richiede un approccio multidisciplinare per combinare consigli dietetici (inizialmente digiuno e somministrazione endovenosa di liquidi ed elettroliti, a cui deve seguire una dieta a basso contenuto di grassi e ad alto contenuto di proteine dopo le dimissioni), un’eventuale terapia antibiotica (in casi selezionati) e farmaci per controllare il dolore.
«Quando possibile, nella forma acuta è fondamentale trattare anche la causa di base, come i calcoli alla cistifellea, e monitorare gli altri organi, in particolare fegato e reni», specifica il dottor Goss. «Infatti, la pancreatite acuta scatena un’infiammazione sistemica molto importante che può condurre a un’insufficienza renale acuta oppure a distress respiratorio acuto, una condizione clinica potenzialmente mortale a carico dei polmoni».
Nella forma cronica infine, dove il dolore è persistente, si può anche ricorrere a una metodica endoscopica mininvasiva, la splancnicectomia, che consente di bloccare il ganglio nervoso che trasmette lo stimolo doloroso.
Fai la tua domanda ai nostri esperti