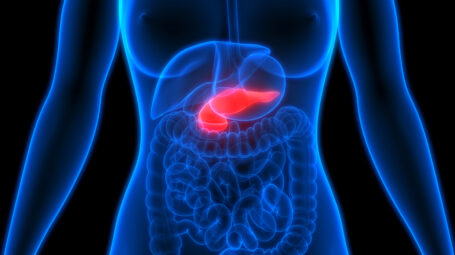La storia di Emanuela: «Facciamo squadra di fronte al tumore al seno»
Consigliera di Europa Donna Italia, Emanuela Tavella racconta di quando le è stato diagnosticato un tumore al seno triplo negativo, l’impatto delle parole dell’oncologo, i momenti di rabbia. E sottolinea l’importanza di fare squadra e il ruolo di Donne in Meta

In medicina siamo abituati ad associare il termine “positivo” alla conferma di una certa malattia o di una specifica condizione clinica, mentre l’aggettivo “negativo” sembra rassicurare. Questa regola non vale per il tumore al seno triplo negativo, il cui nome deriva dal fatto che – a differenza di altri tumori mammari – non presenta nessuno dei recettori utili per le cure. In altre parole, è il più aggressivo dei tumori al seno, quello più ostico da trattare, nonostante i tre “meno” che lo qualificano. Triplo negativo indica, infatti, l’assenza del recettore dell’estrogeno (ER), di quello del progesterone (PR) e del recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano (HER2), con la conseguente impossibilità di ricorrere alle terapie attualmente disponibili per altri casi di tumore al seno.
Nel 2015, di questo carcinoma si è ammalata Emanuela Tavella, oggi consigliera di Europa Donna Italia, che a distanza di otto anni dalla diagnosi racconta la sua esperienza e il suo impegno sociale verso altre pazienti oncologiche.
Emanuela, al momento della diagnosi, avevi già sentito parlare della tua malattia?
«Conoscevo il cancro al seno e avevo ipotizzato che potesse trattarsi di quello. Cinque mesi prima, una carissima amica mi aveva raccontato di aver sentito una sorta di “sassolino” sottopelle, a livello del seno, che poi si era rivelato un tumore. Quando è successa la stessa cosa a me, ho ripensato alle sue parole, per cui ero abbastanza preparata. Così mi sono rivolta subito al medico, che mi ha prescritto un’ecografia mammaria urgente, a cui è seguita a ruota la visita senologica. All’epoca, però, i tempi di diagnosi erano più lunghi rispetto a quelli attuali, per cui il referto istologico è arrivato parziale: inizialmente, quindi, sapevo solamente che si trattava di un carcinoma mammario infiltrante. La notizia del “triplo negativo” è arrivata in un secondo momento».
Ricordi le parole dell’oncologo?
«Perfettamente. Nei giorni precedenti, avevo parlato con mio marito di tutte le tipologie di tumore al seno e, fra le altre, gli avevo descritto anche il triplo negativo, perché avevo seguito la storia di alcune donne a cui era stato diagnosticato e che purtroppo non ce l’avevano fatta. Quando l’oncologo ci ha detto: “Il suo tumore non risponde alla terapia ormonale né ai farmaci a bersaglio molecolare diretti contro HER-2: si chiama triplo negativo”, mio marito ha traballato sulla sedia e io ho sentito un tonfo al cuore. Ma il medico ha anche aggiunto che il mio carcinoma era caratterizzato da una proliferazione molto elevata, un elemento che poteva giocare a mio favore, perché spesso quella tipologia di triplo negativo rispondeva alla chemioterapia. Non ho esitato un attimo e ho chiesto di iniziare le cure il prima possibile».
A chi hai impiegato più tempo a raccontarlo?
«A nessuno, in realtà, perché ho subito comunicato a tutti la notizia. Ero certa che avrei preso forza dagli altri e, allo stesso tempo, non volevo compassione: sapevo che, in questi casi, la gente mormora alle spalle di chi è malato, senza trovare il coraggio di parlarci direttamente, come se “tumore” fosse una parola tabù, da non pronunciare mai di fronte a chi ce l’ha. Per questo motivo, anche al lavoro ho intavolato subito il discorso, spiegando che la mia patologia mi avrebbe imposto degli stop e delle terapie».
C’erano stati altri casi di tumore in famiglia?
«Dieci anni prima, nel 2005, mio papà era stato operato di tumore al colon-retto. Poi, nel 2009, nuovamente al polmone. La prima volta, eravamo tutti spaventati, non sapevamo come comportarci e cosa dire: così lui, forse anche percependo la nostra paura, si era chiuso in sé. Un giorno, insieme a mia sorella e mia mamma, ho deciso di parlargli: gli ho detto che il suo era sicuramente uno dei tumori più terribili, ma che la chirurgia era riuscita a rimuoverlo, insieme a oltre trenta centimetri di intestino, e che senz’altro avrebbe dovuto fare delle terapie pesanti, ma indispensabili per non morire. Da quel momento in poi, si è allentata la tensione e lui è tornato a vivere: tra l’altro, ha avuto la fortuna (e il coraggio, perché ha scelto lui) di entrare in una sperimentazione a Pisa, dove stavano iniziando a somministrare la chemioterapia attualmente in uso per quel tipo di tumore, e oggi è ancora con noi. Grazie a quell’esperienza, ho capito che parlare della propria malattia e darle un “nome” aiuta ad affrontare meglio l’intero percorso».
Ne hai parlato anche con tua figlia?
«Sì, all’epoca Eleonora aveva solo cinque anni, ma ho cercato un modo per raccontarglielo. A dire il vero, è stata lei ad anticiparmi: una sera, dopo averle detto che la mattina successiva non mi avrebbe trovata perché dovevo andare dal dottore, mi ha chiesto perché ci andassi così spesso. Ho colto l’occasione per dirle che avevo sentito un pallino nel seno e che dovevo operarmi. Lei, con la meravigliosa semplicità dei bambini, mi ha risposto: “Stai tranquilla, mamma. Ti fanno un taglietto, tolgono il pallino e non avrai più male”. L’ho ringraziata e mi sono sentita il cuore più leggero».
Si dice spesso che, all’inizio, ci si pone domande che cercano un movente, una causa, qualcuno con cui potersi infuriare. “Come ho fatto a non accorgermene?”. “Perché nessuno ha fatto qualcosa?”. “Chi ha sbagliato?”. Anche tu hai provato quel senso di rabbia?
«Non sono mai stata arrabbiata con la vita o con la malattia, però mi è capitato di provare rabbia verso alcune persone: per esempio, verso quelle che per strada si giravano dall’altra parte e se ne andavano o quelle che non mi offrivano aiuto nelle giornate in cui ne avrei avuto più bisogno. All’inizio, ho provato rabbia anche verso mio marito Vittorio: ero arrivata addirittura a dubitare del suo interesse nei miei confronti, perché non lo vedevo mai triste. Una sera ho sbottato contro di lui, l’ho accusato, finché è scoppiato a piangere. In quel momento mi sono sentita crudele, ma soprattutto ho capito che la sua serenità era solo apparente, un modo per non accollarmi un ulteriore peso psicologico. In quel momento, ho compreso quanto possa essere utile un confronto con gli psiconcologici: non soltanto per i pazienti, ma anche per i famigliari».
Quanto è importante fare squadra di fronte alla diagnosi?
«Fare squadra è indispensabile. È giusto prendersi un po’ di tempo per restare sole con sé stesse, perché dopo la diagnosi è normale sentirsi disorientate, preoccupate, disperate. Poco per volta, però, bisogna trovare la forza per condividere la propria esperienza con altre donne che hanno vissuto o stanno vivendo la stessa esperienza, ma anche con le figure sanitarie, con le associazioni di categoria, con la società in generale. Questo aiuta a ridimensionare la paura, fa sentire meno sole».
Che ruolo ha Donne in Meta nell’essere al fianco delle donne?
«Donne in Meta è un progetto promosso da Gilead Sciences in collaborazione con Europa Donna Italia, con il patrocinio di Susan G. Komen Italia e, da quest’anno, con la comunità delle oncologhe italiane rappresentata da Women for Oncology per fare squadra con le pazienti colpite da tumore al seno triplo negativo. Il nome di questa campagna trova ispirazione nella terminologia del rugby, dove andare in meta rappresenta un’azione che fa punto e che necessita di una squadra collaborante. Ma allo stesso tempo, meta sta per metastatica. L’obiettivo è informare le donne sulle migliori cure disponibili, ma anche sui servizi, sulle possibilità di avere una buona qualità di vita nonostante tutto».
Un ultimo consiglio per le donne che stanno vivendo il tuo stesso percorso…
«Quello di mettersi in primo piano. Noi donne siamo abituate a pensare alla famiglia, agli amici, al resto del mondo, mai a noi stesse. Di fronte alla malattia, invece, dobbiamo pensare anche a noi, ma cercando di dare il nostro contributo ad altre pazienti. Impegnarmi nell’associazione Europa Donna Italia mi ha aiutata e mi aiuta tantissimo, perché il volontariato è il più grande regalo che la vita potesse farmi. Dà un senso al mio essere ancora qui, nonostante tutto. Lo dico sempre a ogni donna spaventata: “Anch’io ho pensato, e spesso penso, di morire. Ma sono ancora qua”. Anziché pensare a come finirà poi, viviamo ora».
maggio 2023
- LEGGI ANCHE: Che cos’è #zittocancro: la storia di Dykadj
Fai la tua domanda ai nostri esperti